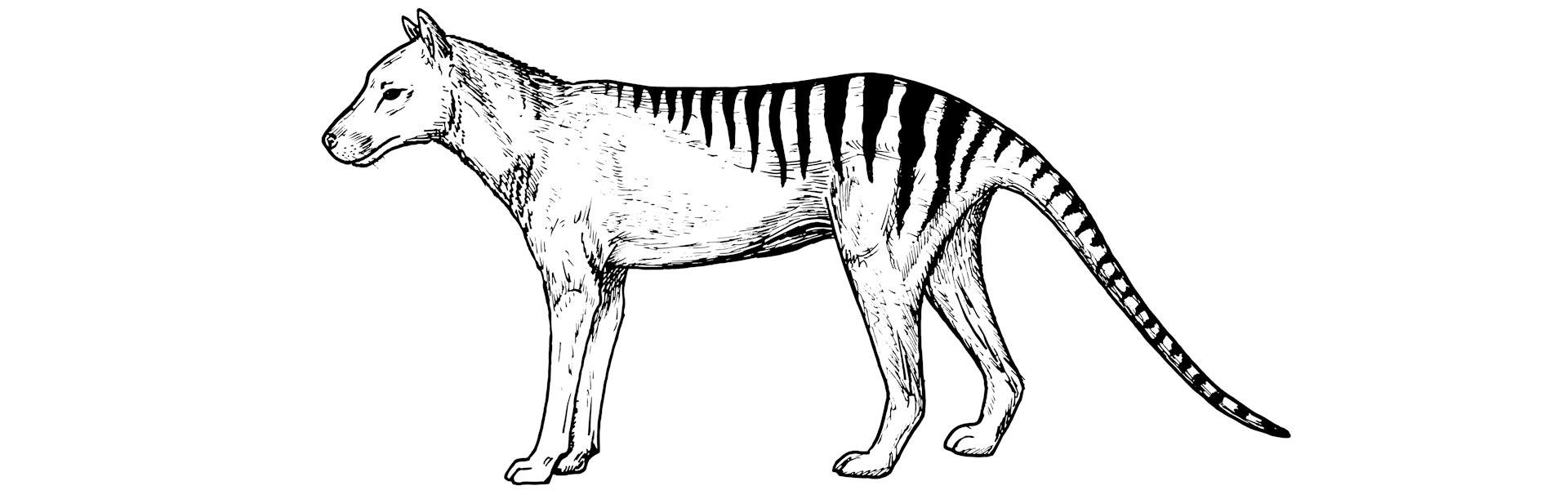L’ultima volta aveva vomitato. Aveva lasciato credere che si trattasse di influenza e aveva chiesto di uscire. In infermeria, rimase solo ad aspettare. Sperava almeno di riuscire a imbrogliare il medico. La paura gli aveva calato un sacchetto sulla testa e non era sicuro di poter far finta di niente. S’era ripulito dal vomito ma non era riuscito a togliersi il sapore dell’asfissia.
La luce fredda dentro cui era immerso non smetteva di rimbalzare dalle assi che imitavano quattro pareti ai bordi di ferro della lettiga per punzecchiargli gli occhi. Cercava di non cedere alla provocazione rimanendo seduto, immobile, con le gambe penzoloni. Ma le pezze, il lenzuolo, la carta. Rimaneva tutto troppo bianco in quella baracca adibita al primo soccorso.
«Bianco come il paradiso», pensava, «dove non si distingue la fine del cielo dall’inizio dell’infinito», «confuso come l’inferno», si ripeteva, dove non si capisce sotto quanti metri di terra si possa continuare a vivere. «Come una ghiacciaia dove conservare quello che va a male troppo velocemente», dedusse.
Il cuore batteva fino alle tempie e le gambe non smettevano di essere molli. Di nuovo, lo assalì il vomito. Poi bianco. Poi, di nuovo, niente.
Quando gli occhi tornarono a schiudersi, dall’alto, tante facce deformi lo fissavano da ogni direzione. «Come le spine della corona di Cristo», pensò. Mostri dalle guance gonfie e dai nasi incassati. Specie di umani che dovevano essere forse amici, parenti o compagni, «difficile ora riconoscerli ma comunque impossibili da dimenticare».
Eccole lì, tutte le sue paure. Pendevano irriconoscibili su di lui. Era sicuro che sarebbero venute a trovarlo tutte le notti e ogni volta che si fosse trovato in bilico tra la veglia e il sonno, quando proprio non sarebbe stato possibile capire se stesse sopraggiungendo la morte o solo un’assenza momentanea.
Qualcuno gli infilò in bocca un grano di sale, poi, dopo qualche vociare, una zolletta di zucchero. E Antonio si trovò a non saper decifrare neanche il sapore dell’imbarazzo. Gioia era arrivata lì, avvertita da qualcuno, a tenergli la mano.
Arrivò il dottore, entrò e si lasciò ingannare. Gli prescrisse qualche giorno di riposo e qualche visita. «Routine», l’aveva rassicurato.
In realtà, tutti sapevano che era pagato per evitare incidenti e soprattutto per scongiurare il pericolo che gli uomini venissero contagiati dal morso di quell’animale che, di tanto in tanto, si riaffacciava per divorare qualcuno. La paura era un veleno troppo potente per la gente che scendeva nella terra da viva e lottava per rimanerci. La stessa gente che era cresciuta abitando il buio fino a scandagliarlo con il proprio corpo per sottrargli giorno dopo giorno qualche metro cubo. Il medico era pagato per interrompere il contagio epidemico, isolare la vittima, suggerire una cura che neutralizzasse l’attenzione e abbassasse la stima della valutazione dei rischi. L’idoneità al lavoro era una cosa difficile da guadagnarsi.
E Antonio usò i giorni di riposo per provare a guarire.
Ogni volta che gli sembrava di aver sconfitto la bestia, vedeva nitidamente crescere da lontano quel lampo bianco, bastardo, che tornava a prenderselo per portarlo chissà dove. Nonostante gli sforzi finiva sempre più spesso in una qualche locale di incoscienza da cui ne usciva solo alla presenza di quei mostri piegati e guardinghi che, con qualche espediente, erano capaci di rimetterlo in piedi dopo ogni mancamento.
«Solo un prelievo», dicevano per essere sicuri che non ci fossero patologie.
E in effetti, al cuore e alla testa non c’era niente, dentro ai polmoni neanche. Era sano. Dunque, poteva vivere.
Antonio sperava di poter contare ancora su qualche malfunzionamento che giustificasse il comportamento di quell’enorme corpo che gli apparteneva ma gli disubbidiva e combatteva a suo modo per non tornare nel buio.
Su consiglio del dottore, Gioia gli procurò qualche corroborante e sonniferi, in dosi necessarie a sottrarsi ai morsi di quello stato di veglia.
Ma l’inquietudine lo azzannava senza preavviso, anche all’aperto e in pieno giorno. Allora Antonio trovò più rassicurante chiudersi in casa e guardare Gioia mentre il vapore del ferro da stiro si gonfiava e scappava via dalle finestre aperte. Il dottore passava il tempo dei loro appuntamenti ad annuire e prolungare il numero di giorni di riposo.
Quando alle sei e trenta di quarantadue giorni dopo infine si presentò ai cancelli, trovò i picchetti. La sua apnea per quel giorno poteva interrompersi.
Franco e gli altri avevano incrociato le braccia davanti al buco che li inghiottiva ogni giorno. Due porte di ferro che li separava dal mondo e li trasferiva in gabbia dentro la pancia della terra. Antonio si era piazzato insieme a loro, in piedi, con le gambe larghe e braccia incrociate e si sentì sollevato per quell’alibi inaspettato. Quel giorno non si sarebbe infilato nel montacarichi che lo avrebbe iniettato a centottanta metri sotto terra.
Pensava che si sarebbero limitati a fischiare e battere i ferri contro le cancellate di quell’azienda che, prima aveva conquistato la concessione del governo e, poi, aveva declassato la miniera a cava e, adesso, usava i metodi della contrattazione privata per licenziare chi riteneva superfluo. Ma, al di là delle ore di lavoro tirate via dalle buste paga, a tutti era chiara una cosa: le estrazioni non c’entravano. Lì c’era la bauxite migliore di tutta l’Europa. Il problema erano le malattie strane. Chi poteva esibirne una era già salvo in qualche modo. Gli altri, erano un problema da risolvere in fretta e volentieri i padroni avrebbero scaricato tutto di nuovo al governo, nel bilancio vagabondaggio o sanatori. L’importante era non impensierire troppo i soci di capitale.
Nel frattempo, i dottori ingegneri avevano ricevuto indicazioni per non attivare le idrovore in fondo ai tunnel più vecchi e il lago, da sotto, spingeva. Chi rimaneva a lavorare nelle vie scavate di fresco vedeva l’acqua andargli incontro e coprirgli le caviglie. Allora si era costretti a salire e tornare a centosessanta metri, centoventi a volte. Lì, a spremere le vene già battute, ci voleva più tempo. Qualcuno nei successivi ventidue giorni continuò a scendere sfilando tra i picchetti.
Quando ci fu il cedimento delle travi a volta sullo slargo che apriva la strada ai cunicoli in direzione nord est, tutti capirono che i picchetti erano stati e sarebbero rimasti controffensive inutili.
«Occupazione», votarono. Se sulla terra erano rimasti invisibili, nelle viscere, forse, avrebbero potuto contare di più: trasformandosi in una molteplicità di piccole schegge infilate sotto pelle, speravano di diventare purulenti. Scendere e occupare il ventre cavo della miniera.
Antonio al pensiero, si trovò a correre nel gabinetto e dentro quel buco dall’odore stomachevole della fossa restituì tutto quello che non aveva avuto la forza di dire in assemblea.
L’idea di difendere il granchio vuoto che da sottoterra aveva succhiato la vita di molti non gli pareva possibile.
Con Franco ci aveva condiviso la vita, i giochi, la strada, l’assunzione, i tuffi al mare e lo spazio del montacarichi nelle mattine degli ultimi diciassette anni. L’ultima lite in assemblea l’aveva squarciato ma fu proprio al termine di quella mezz’ora di voci grosse e pugni trattenuti nei palmi che ebbe una sola certezza: sottoterra, era impossibile tornare a scendere. La paura aveva in mano un laccio intorno ai polmoni e come un cattivo ammaestratore lo stringeva senza riguardi né motivo. Sarebbe bastato il peso del casco, il rumore dei chiodini delle scarpe, le mani nei guanti per tornare a vedere tutto bianco. Nulla. Troppo vomito nel suo stomaco e nessuna diagnosi ai polmoni.
Così, seppe di avere solo due possibilità. Tornare a far nulla, tradire i compagni e prendere quanto gli spettava mentre loro provavano a resistere per giungere, infine stremati, ad arrendersi e elemosinare qualcosa contrattando al ribasso, oppure morire.
Ma subito.
Prima che il padrone rescindesse il contratto.
Prima che la silicosi si prendesse qualcun altro e lo fregasse.
Doveva sbrigarsi. Non voleva più contrattare con quel buco da cui fino al giorno prima erano usciti cibo e vestiti e libri e sogni ma che, in cambio, aveva divorato almeno un uomo per ogni famiglia. Un idolo cattivo che non aveva chiesto in sacrificio vergini inermi ma si era preso gli uomini più vigorosi.
Non era il disagio di trovarsi sconfitto, né la certezza che presto sarebbero arrivate anche per lui le analisi, le cure, il ricovero, la lunga degenza, né il dolore di trovarsi senza respiro come aveva visto avvenire al corpo del padre.
Era il buio. Non importava che ci fosse, il sole, la tempesta o la pioggia. Che facesse freddo o caldo. Ogni mattina, si trattava di fendere il buio sempre uguale e ricevere in cambio il viso grigio e un corpo troppo bianco.
Se avesse tradito sarebbe rimasto solo in un paese che viveva per quell’animale nascosto.
Se avesse tradito sarebbe morto comunque. Per Franco, per la Squadra nove, per l’oste, anche per il prete forse.
Doveva sbrigarsi e decidersi.
Passò in piazza e chiese una cicca. «Ma tu non fumi». «Ho smesso. Adesso ricomincio». Aspirò e buttò fuori. Gli piaceva ancora. Nascosto dal fumo ricominciò a pensare e si incamminò senza meta tra le casupole. Poteva ammalarsi. Ma ci voleva del tempo. No. Doveva essere più pratico. Doveva morire rapidamente. Senza lasciare traccia delle sue intenzioni. Senza indizi nel corpo. L’assicurazione non doveva avere scuse; doveva pagare i suoi quarantadue anni.
Il lampo bianco l’aveva salvato dalla tentazione di lottare inutilmente. I medici gli avevano regalato più giorni di vacanza di quanti se ne fosse mai potuto permettere da quando era poco più che un ragazzino. I picchetti erano stati salvifici e l’occupazione gli aveva allungato ancora quella vita.
Ma adesso era meglio morire. E non era triste.
Gli dispiaceva solo per Gioia che aveva provato con lui a diventare madre per almeno due volte e che invece non era riuscita. Aborti spontanei, dicevano, ma, nei feti che gli avevano raccontato le ecografie, di spontaneo non c’era niente.
Non gli avrebbe certo fatto paura il buio nella bara sotto soli due metri di terra. Sarebbe stato in buona compagnia. Sorrise contando tutti quelli cui era sopravvissuto.
La casa dei nonni. Allungò il giro. Salì dietro l’abitato da cui si snodava una stradina nel bosco. Almeno quello era rimasto come quando ci andava a giocare da bambino, quando sua nonna abitava a mezza collina nella radura. Vicino alla casa, qualche anno prima l’azienda di fornitura elettrica ci aveva piantato un palo grosso come un albero per aumentare la portata: l’avevano pagato bene per quello spazio occupato. I soldi erano stati buoni a saldare i debiti per i funerali dei nonni e poi del padre e il convitto per il fratello che adesso viveva e si imbarcava da Genova.
Il bosco era umido in quella stagione e i pioppi non avevano ancora intenzione di far nevicare polline. Quando lo facevano, riuscivano a coprire l’intera valle e il paese di batuffoli bianchi che rotolavano insieme formando una coperta soffice come lana appena cardata. La lana.
La nonna e il nonno imbottivano materassi. Era così che avevano sfamato i figli e qualche nipote. Curavano le pecore e si affaccendavano attorno alle vasche di pietra. Era tutto ancora lì. Anche i muretti sui quali si arrampicavano Antonio e il fratello. In piedi ma vuoto.
Si spinse più su a curiosare tra i ricordi.
«Quanto si guadagna a cardare la lana nonna?» «Meno della fatica che ci vuoi mettere, va’ spostati, lascia, che non sei capace» E quanta lana ricordava. Una montagna dentro cui saltare. Provava a nuotare tra una nuvola e l’altra, si impegnava in salti lunghi che imitassero il volo. E così facendo finiva col tuffarsi in quella materia arruffata che sapeva ancora di bestia e altopiano.
«Le zecche» gridava la nonna, quando Antonio e il fratello rotolavano nella prima vasca. Poi la sera li passava a setaccio. Con le pezze imbevute d’alcool e il pettinino stretto che graffiava sul cuoio capelluto. Un supplizio fatto di carezze e del fiato della nonna.
Era nella seconda e terza vasca, dove la lana subiva il lavaggio e il risciacquo, che i piedi, nel gioco diventavano pesanti come quelli degli avventurieri intenti a uscire dalle sabbie mobili. Un triplo salto mortale e poi giù di schiena, senza dolore. La lana pressata dal peso dell’acqua era un tappeto elastico da cui, ad ogni pressione, sgorgavano piccole conche.
E puntuale arrivavano le furie della nonna «La saponina». Ne metteva a quintali. Tritata.
«Madonna santissima che questa è per i vermi e le cimici». E lì erano dolori. La nonna prendeva il battipanni e dopo averglielo menato sul didietro correva alla lana. La tirava su ancora arruffata e batteva anche quella e poi giù altre manciate di polvere e poi a lavarla di nuovo per poterla domare e così via.
«Nonna ma perché?» Piangeva Antonio guardandosi i ghirigori violacei sulla pelle. «È velenosa disgraziato. Ricordati del cane quello scemo. Quello che si è mangiato le palline rosse. Invece di scovare i funghi s’è andato a ingozzare delle bacche lucide». «Ma nonna quale? Quale?», «E come è morto?», «E che ha sentito?», «E poi?» «E nonna è brutta la morte?» «E che si sente? Fa paura?»
Ed era allora che la donna, con le dita curve e le nocche gonfie di lavoro e artrite diventava silenziosa e smetteva di essere quel mostro granitico che i nipoti temevano notte e giorno. Era come se la morte del piccolo cane scemo le mettesse addosso una strana tristezza per avvicinarle, più di quanto mai avrebbe voluto, la natura finita del presente. Allora, come avviene dopo una puntura d’insetto che è meglio dimenticare per non grattarsi più, si scuoteva e tornava imperiosa. «Vatti a lavare va’, anche tu, prima che ti venga qualcosa. Che ci ho messo il trito rosso. E tutto me l’avete fatto sprecare». «Vedrai tu se non muoiono le cimici, vedrai se non me la compra nessuno la lana, vedrai». La morte era stata battuta dalla paura del presente.
Sarebbe stato bello essere come la nonna. La paura del presente invece adesso, pensava Antonio, stava superando anche la morte.
Il ricordo dei giorni seguenti ai bagni nelle vasche di lana grezza tornarono ad affacciarsi come un prurito.
Nonostante la nonna li avesse sciacquati con forza dentro il badile dei panni e li avesse strigliati cambiando spesso acqua, il sapore acre del pepe che aveva sentito nel naso si trasformava in dolore e gli regalava la sensazione sgradevole di masticare un riccio di castagna misto a grani di vetro. Il veleno, anche quel poco con cui s’era bagnato, era sempre capace di gonfiargli l’interno delle guance e la lingua e l’ingresso del naso e le palpebre. Si sforzava di fare finta di niente per non dar ragione alla nonna ma una miriade di spilli spingevano dalle mucose per trapassare la pelle. Era in quei pomeriggi passati al chiuso, in penombra, perché il sole non finisse quel che il veleno non era riuscito a iniziare che si divertiva a fantasticare ancora. Si immaginava che quel fiore bitorzoluto e tanto strano lo trasformasse in un mostro indomito a cui sarebbero spuntati aculei lunghi e duri come quelli degli istrici. E poi, compiuta la trasformazione, avrebbe fatto paura a tutti e sarebbe stato invincibile, avrebbe potuto superare il mare con un solo balzo, volare davvero o scavare gallerie nella terra. Ma una estate, dopo l’ennesimo tuffo proibito, durante la reclusione, anziché aculei spuntarono peli di barba che ricoprirono di un’ombra nera il viso e il collo. E fu l’ultima estate trascorsa a giocare dai nonni. Poi la miniera, poi la vita.
«Buffo», pensò Antonio, «a sapere che scavare la terra sarebbe stato così inconcludente, avrei davvero provato a imparare a volare. Guido ci ha visto bene che se ne è andato pe mare».
A due settimane esatte dall’inizio dell’occupazione della miniera, suo fratello, ufficiale di macchina in marina, salpava di nuovo da Genova ma non per lavoro.
Avevano trovato Antonio riverso bocconi nel bosco dietro il paese. Sporco, nella pozza di fango e vomito dentro cui era caduto. Rappreso in una espressione di stupore e disgusto. L’autopsia non aveva saputo dare alcuna spiegazione.
Gioia continuava a chiedersi perché non avesse usato il sonnifero invece di quelle calle schifose, ma un suicidio è più scomodo di un incidente, pagarono più del dovuto e lei imparò a soffocare le domande.
Franco davanti alla bara ringraziava l’amico per avergli dato una scusa buona per uscire qualche ora dalla miniera e poter piangere tutte le lacrime che aveva perché, nel frattempo la paura, quella vera, s’era impadronita di paese e miniera e, già prima di quella mattina in cui le campane suonavano a morto, tutti sapevano che presto si sarebbero arresi. Il ragno vuoto aveva vinto la sua carcassa.
Arum Italicum
Conosciuto anche come gigaro chiaro è una piccola pianta spontanea che ama l’ombra e l’umido. Le foglie crescono da autunno a marzo per poi lasciare il posto a una inflorescenza che prende le forme di una spiga carnosa avvolta da una foglia modificata, detta spata, di colore bianco. Tossica, ha imparato a mettere in atto una serie di strategie seduttive per l’impollinazione e la riproduzione. Nel periodo della fioritura, emana puzza di carogna e la spada, che si scalda a fasi alterne fino a produrre un calore ben percepibile (da cui il nome arum) ne aumenta la volatilità, attirando mosche ed altri comuni ditteri. Più frequente nei sottoboschi a ridosso delle radure erbose è molto diffuso sul territorio italiano e deve probabilmente i suoi nomi popolari come pan di serpe ed erba biscia alla sua totale tossicità.
Nei boschi è facile incontrare la pannocchia delle bacche isolate e senza foglie. Il componente velenoso contenuto nei cristalli di ossalato di calcio scompare con la cottura tanto che, fino a qualche decennio fa, veniva largamente usata dalle popolazioni contadine che ne mangiavano i tuberi dopo lunga bollitura o l’essiccazione. Senza tali accortezze, però, il contatto con la pelle provoca dermatiti e, negli anni, sono stati registrati casi di avvelenamento per ingestione dei grani della spata, soprattutto in animali di piccola taglia e nei bambini perché non è affatto facile ingerirne grandi quantità per via dell’immediato dolore che provoca la loro masticazione.
Poiché è ricca di grassi e saponina, una volta polverizzata veniva usata come insetticida, contro vermi e altri parassiti. La foglia, bellissima, screziata a forma triangolare e l’inflorescenza carnosa che svetta rigida verso l’alto sono state assunte come augurio di crescita e potenza. Non a caso, nonostante fosse notoriamente velenosa è stata spesso riprodotta tra gli apparati decorativi della Roma classica e anche oltre. A Roma si trova tra le decorazioni naturistiche dell’Ara Pacis e giace, da anni, nel quadrante destro (in basso) della Fontana di Trevi.